Indice dell'articolo
ToggleSono infiniti i reati informatici e i pericoli che si corrono sul web, soprattutto quando si è molto giovani e vulnerabili e non si ha ancora una chiara distinzione tra ciò che è bene e ciò che è male. E non stiamo parlando solo di cyberbullismo, o della possibilità di cadere nelle trappole tese da pedofili e malintenzionati: negli ultimi anni, su Internet e sui social si è diffusa una nuova minaccia, quella delle sfide estreme che – in alcuni casi – possono portare persino alla morte dell’utente.
Il ruolo dei social nelle sfide estreme (e pericolosissime)

Inizialmente a balzare agli onori della cronaca fu la Blue Whale Challenge, un macabro “gioco” nato in Russia che, attraverso una serie di tappe che il ragazzo/a deve raggiungere con l’aiuto di un curatore (tagli sulle braccia, visione in loop di video violenti, comportamenti pericolosi ecc.), dopo 50 giorni conduce sino al suicidio. In realtà, i dati in merito alla Blue Whale sono contraddittori: c’è chi parla di oltre 100 morti riconducibili alla sfida, chi la ritiene una bufala. In realtà, si tratta di una sorta di isteria collettiva nata da un fenomeno che – nato sul web – aveva coinvolto solo poche persone per poi diffondersi in maniera preoccupante dopo che, della storia, hanno parlato i media. E, così, è stato anche per la Blackout Challenge: qui non si tratta di un percorso, ma di una folle sfida che consiste nel legarsi qualcosa al collo per perdere i sensi per pochi secondi. Una sfida che, talvolta, è sfociata in una accidentale morte.
Al di là dell’evidente follia di chi a queste sfide dà vita, è fondamentale soffermarsi sul ruolo che i social network e i media in generale giocano in vicende tanto delicate: parlarne con enfasi, diffondere video, raccontare tali sfide con dovizia di particolari porta con sé il rischio d’emulazione. E il rischio che si diffonda – per l’appunto – un’isteria collettiva.
Cosa dovrebbero fare, dunque, i media? Distinguere il dovere professionale di raccontare dal dovere etico di rendere proporzionale il racconto ai fatti. Fondamentale è non ingigantire i fatti, non riportare segnalazioni di casi non verificati, non confondere gli utenti e – soprattutto – non mitizzare le vicende donando loro un interesse che non meritano. Anzi, in casi come questo non parlarne aiuta: “Questa gente disturbata ha potere soltanto se glielo diamo noi: se i genitori lasciano che i figli giovanissimi parlino con gli sconosciuti e girino su Internet senza tenerli d’occhio e senza spiegare loro com’è il mondo; se si crede a tutto quello che si vede su Internet; se i giornalisti presentano questi adescatori come dei geni della perversione e si attaccano a etichette di facile presa come appunto la Blue Whale Challenge, che esiste e fa danni solo se crediamo che esista e gli diamo visibilità senza fare critica. Più la pubblicizziamo e ci concentriamo sul mito, parlandone in toni di certezza, più la rinforziamo e facciamo il suo gioco”, si legge sul sito di Attivissimo.
Che cos’è il reato di istigazione al suicidio

Ma quale reato c’è, dietro vicende come la Blue Whale Challenge o la Blackout Challenge? In Russia, la polizia ha arrestato diverso tempo fa il 21enne Philipp Budeikin, con l’accusa di aver istigato al suicidio alcuni giovani e di aver diffuso il fenomeno in rete. Pare abbia anche confessato, ma non ci sono fonti certe a riguardo. Ciò che è certo è che, in Italia, ad oggi ancora non è stato arrestato nessuno per tali sfide, sebbene anche da noi girino video su YouTube e ci ci siano gruppi Facebook che propongono sfide estreme.
Al di là del nome che la sfida del momento assume, in casi di questo tipo il reato che si configura è uno: l’istigazione oppure l’aiuto al suicidio, che si attua secondo due diverse modalità. Nel primo caso c’è il rafforzamento dell’altrui proposito suicida, ovvero sia la facilitazione dell’azione suicidiaria altrui: perché il reato possa essere imputato, però, è necessario dimostrare che l’azione dell’accusato abbia effettivamente condotto al suicidio della vittima, e che tale azione sia stata da lui attuata con tale preciso obiettivo. Per aiuto al suicidio, invece, si esclude l’esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui, presupponendo anzi che l’intenzione di autosopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vittima. L’accusato, in questo caso, va a fornire “solamente” un contributo di tipo agevolatore (di tale reato è stato accusato ad esempio Marco Cappato dei Radicali, per aver facilitato il suicidio assistito in Svizzera di Dj Fabo).
Quando non si giunge al suicidio, ma alla realizzazione di lesioni autoinflitte, difficilmente si arriva ad ipotizzare un reato: nel nostro ordinamento è infatti previsto il reato di istigazione a commettere un delitto, ma non è questo il caso dal momento che il soggetto fa del male solo a se stesso. C’è chi parla poi la circonvenzione di persone incapaci (art. 643 del Codice Penale), che prevede una reclusione da due a sei anni e che però è un caso un po’ diverso: tale reato prevede infatti che un soggetto abusi dei bisogni, dell’inesperienza o delle passioni di un minorenne o di una persona in stato di infermità o deficienza psichica, per trarne un profitto. Ma, la Blue Whale e tutte le altre “sfide” di questo tipo, non apportano alcun profitto. Neppure agli eventuali “curatori”.
Quale reato si configura, dunque, per queste challenge? Ciò che meglio le spiegherebbe è il plagio, che era previsto dall’art. 603 del Codice Penale e che recitava: “Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni”.
Tuttavia, il reato di plagio oggi non esiste più. Ed ecco che i responsabili di Blue Whale Challenge & co. difficilmente vengono puniti. Cosa fare, dunque? Tenere gli occhi aperti, sempre. Soprattutto i genitori e gli educatori, ma anche i media che – in casi di questo tipo – svolgono un ruolo determinante.
Fonte Immagini: Depositphotos
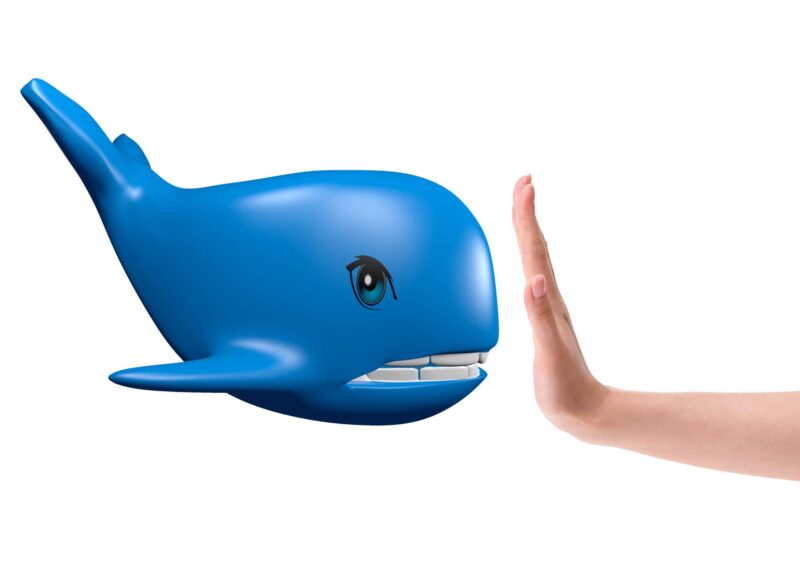







4 risposte
Nell’articolo però non si menziona che il reato di plagio «oggi non esiste più» perché è incostituzionale, infatti prima che venisse abolito è stato utilizzato rarissimamente e solo per persecuzioni a fini ideologiche (vedasi il caso del prof. Aldo Braibanti e il caso di Don Emilio Grasso).
Non viene nemmeno ricordato che quella fattispecie di reato era un «retaggio» del codice penale di epoca fascista: tant’è vero che chi oggi la vorrebbero ripristinare solo pochi militanti e propagandisti dediti alla discriminazione religiosa e spirituale.
Non è certo riportando in auge uno scampolo di fascismo che si risolve l’ipotetico problema di «Blue Whale» e simili.
Nell’ultimo capitolo dell’articolo abbiamo puntualizzato quanto segue
“Tuttavia, il reato di plagio oggi non esiste più. Ed ecco che i responsabili di Blue Whale Challenge & co. difficilmente vengono puniti. Cosa fare, dunque? Tenere gli occhi aperti, sempre. Soprattutto i genitori e gli educatori, ma anche i media che – in casi di questo tipo – svolgono un ruolo determinante.”